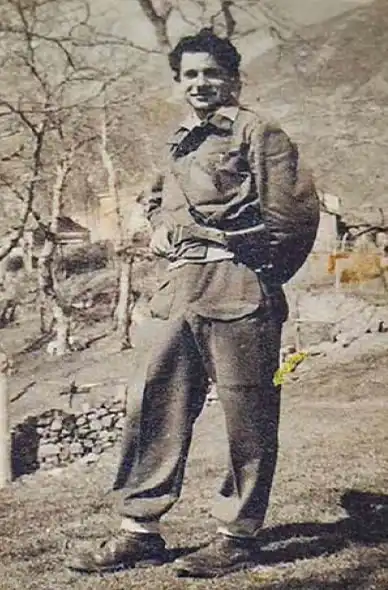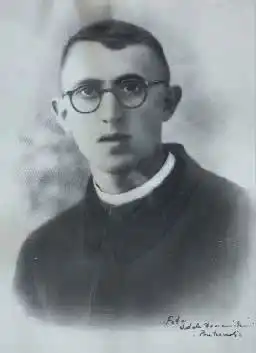COMANO E LA RESISTENZA
COMANO E LA RESISTENZA
L’esperienza della scuola partigiana e il voto alle donne (1945)
L’esperienza della scuola partigiana e il voto alle donne (1945)
Il territorio di Comano dopo l’8 settembre 1943 divenne, per la sua posizione strategica, un importante centro di attività legate alla Resistenza, con la presenza della IV Brigata Apuana, che sperimentò forme di democrazia partigiana
Il territorio di Comano dopo l’8 settembre 1943 divenne, per la sua posizione strategica, un importante centro di attività legate alla Resistenza, con la presenza della IV Brigata Apuana, che sperimentò forme di democrazia partigiana
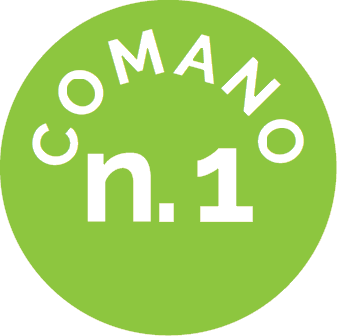
La Resistenza e la guerra ai civili dei nazifascisti
I primi nuclei di partigiani ebbero l’appoggio della popolazione civile e questo causò la spietata reazione nazifascista fin dall’estate del 1944. Tra il 3 e il 4 luglio, nel corso dell’operazione Wallenstein I, che doveva stroncare l’attività partigiana nel comprensorio appenninico e subappenninico delle province di Parma, Apuania e La Spezia, ci fu un rastrellamento che colpì soprattutto i civili. A Catognano fu ucciso un bambino di soli 11 anni, Erminio Bertoli, mentre a Camporaghena furono trucidati Battista Bertocchi, 30 anni, Ermenegildo Bertocchi, 18 anni, Ermenegildo Giannarelli, 27 anni, originari di Sassalbo, e il parroco don Lino Baldini, 28 anni, accusato di essere un fiancheggiatore dei partigiani.
Dopo la formazione della Divisione Lunense e la suddivisione in brigate, nell’agosto 1944, si insediò a Camporaghena la IV Brigata Garibaldi Apuana “Gino Menconi bis”, che operava nelle valli del Taverone e del Rosaro. Il comandante era un antifascista di Carrara già sottoposto a confino, Almo Bertolini, detto «Oriol», in seguito affiancato dal reggiano Reclus Malaguti, detto «Benassi», anch’esso antifascista di lungo corso e confinato politico, che arrivò in Lunigiana dopo che nel febbraio del 1944 era riuscito ad evadere dal carcere di Reggio Emilia e a evitare la fucilazione dei nazifascisti. Tra i dirigenti partigiani locali, si segnalano anche le figure del medico Marco Antoniotti «Astor», Fausto Bocchi «Gianni» e Olinto Zaghett «Carmelo».
La scuola partigiana e le libere elezioni con il voto delle donne
La IV Brigata Apunana fu da subito impegnata in attività di sabotaggio e guerriglia nei territori di Comano e di Fivizzano, ma ciò che la caratterizzò particolarmente fu la capacità di gestire la vita amministrativa del Comune di Comano, con particolare riguardo ai bisogni degli abitanti, a partire dall’istruzione scolastica. Nacque una scuola partigiana intitolata a Ubaldo Cheirasco, studente universitario e partigiano, che si trovava insieme agli uomini del Monte Barca, poi fucilati a Valmozzola. Fu proprio grazie all’intervento di Cheirasco che si salvò dalla morte certa un uomo di Comano, Mario Galeazzi, graziato all’ultimo minuto perché i suoi compagni fanno cadere le accuse nei suoi confronti, facendo credere ai fascisti di averlo arruolato a forza tra i partigiani.
La scuola partigiana fu organizzata per andare incontro alle esigenze dei giovani studenti sfollati e dei numerosi partigiani studenti che, a causa degli eventi bellici, furono costretti ad abbandonare gli studi. Fu articolata in due gradi di istruzione: medie inferiori e superiori, con indirizzo classico, scientifico, magistrale e tecnico; le prime spese furono a carico della IV Brigata Apuana, ed erano previsti aiuti per chi avesse difficoltà finanziarie per pagare l’iscrizione. In un documento della scuola, del 15 gennaio 1945, rivolto al Provveditorato agli studi di Massa, si dichiara l’intento di defascistizzare l’istruzione, dopo gli anni del regime: «risulta abolito l’insegnamento della cultura fascista, del diritto e dell’economia corporativa e ogni insegnamento è stato riportato alla sua funzione storica e scientifica, spogliandolo da ogni sovrastruttura tendenziosa, soprattutto per quanto riguarda la storia politica». La scuola venne organizzata dal prof. Italo Malco, dal maestro Remigio Lucini e dallo studente di Lettere Edoardo Savino Maloni. Il 25 febbraio 1945, si tennero a Comano le elezioni amministrative comunali, libere e democratiche, che videro anche la partecipazione al voto, per la prima volta delle donne (come accadde assai raramente sotto occupazione). Fu eletto a larghissima maggioranza Marco Antoniotti, medico e partigiano, di tendenze liberali. La Brigata inoltre pubblicava un periodico e gestiva spacci alimentari che vendevano generi di prima necessità a prezzi calmierati, in modo da aiutare la popolazione allo stremo. La IV Brigata Apuana fu l’unica a scampare ai terribili rastrellamenti dell’autunno e inverno 1944 e nel mese di marzo del 1945, congiuntamente alla Brigata Garibaldi “Leone Borrini”, fu costretta dalla Missione Alleata di Rigoso a confluìre, non senza dissensi, nella Divisione tosco-emiliana Monte Orsaro, che univa le brigate del territorio parmense con quelle della Lunigiana.
Un episodio controverso è l’uccisione del parroco di Comano don Sante Fontana, attribuita ad alcuni partigiani della IV Brigata Apuana, che negarono gli addebiti, ma ammisero di aver raccolto informazioni sul suo conto. Si creò un drammatico conflitto interno, sia tra i partigiani, sia tra gli abitanti di Comano: alcuni giudicarono il religioso un delatore e quindi un pericolo per la Resistenza e la popolazione che la sosteneva (tra i capi d’imputazione, quello di aver letto i bandi di arruolamento alle armi della RSI dal pulpito), mentre altri giudicarono il suo comportamento dettato da una prudente neutralità e pertanto sostennero che l’omicidio non ebbe una reale funzione bellica, ma sarebbe stato determinato da ragioni politiche e personali
Verso la Liberazione, l’ultima battaglia
Tra il 21 e il 22 aprile del 1945, la IV Brigata Apuana e la Brigata “Leone Borrini” costrinsero alla resa numerose truppe di tedeschi e fascisti, di cui almeno un migliaio furono portati prigionieri proprio a Comano, sede del comando della IV Brigata Apuana. Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, hanno inizio le prime azioni di sabotaggio di ponti, strade e gallerie, allo scopo di isolare Aulla. Alle sei del mattino si verifica il passaggio sulla strada di truppe tedesche con carri armati e pezzi d’artiglieria. Alle tredici una colonna di tedeschi e di repubblichini provenienti dalla Spezia e diretti a Nord entra nell’area di tiro dei Battaglioni e cominciano combattimenti che vanno avanti per tutto il pomeriggio, ai quali partecipano anche l’artiglieria americana e aerei anglo-americani. Verso sera, giungono in aiuto dei nemici artiglierie tedesche, il comandante «Dany» porta i suoi battaglioni sul monte Metti, mentre all’alba del 23 aprile la battaglia infuria a Podenzana. Il 24 aprile giunge la notizia che i tedeschi hanno lasciato La Spezia e che la riva destra del Magra è in mano partigiana, ma il nodo stradale di Aulla è sempre in mano nemica. I partigiani intanto fanno sortite verso Terrarossa, mentre le truppe alleate transitano a Isola di Caprigliola. La mattina del 25 aprile, i battaglioni della Brigata Val di Vara conquistano l’una dopo l’altra le posizioni nemiche e la liberazione è raggiunta quando ai partigiani si uniscono due colonne americane che arrivavano da Nord-Est e da Sud.
La Resistenza e la guerra ai civili dei nazifascisti
I primi nuclei di partigiani ebbero l’appoggio della popolazione civile e questo causò la spietata reazione nazifascista fin dall’estate del 1944. Tra il 3 e il 4 luglio, nel corso dell’operazione Wallenstein I, che doveva stroncare l’attività partigiana nel comprensorio appenninico e subappenninico delle province di Parma, Apuania e La Spezia, ci fu un rastrellamento che colpì soprattutto i civili. A Catognano fu ucciso un bambino di soli 11 anni, Erminio Bertoli, mentre a Camporaghena furono trucidati Battista Bertocchi, 30 anni, Ermenegildo Bertocchi, 18 anni, Ermenegildo Giannarelli, 27 anni, originari di Sassalbo, e il parroco don Lino Baldini, 28 anni, accusato di essere un fiancheggiatore dei partigiani.
Dopo la formazione della Divisione Lunense e la suddivisione in brigate, nell’agosto 1944, si insediò a Camporaghena la IV Brigata Garibaldi Apuana “Gino Menconi bis”, che operava nelle valli del Taverone e del Rosaro. Il comandante era un antifascista di Carrara già sottoposto a confino, Almo Bertolini, detto «Oriol», in seguito affiancato dal reggiano Reclus Malaguti, detto «Benassi», anch’esso antifascista di lungo corso e confinato politico, che arrivò in Lunigiana dopo che nel febbraio del 1944 era riuscito ad evadere dal carcere di Reggio Emilia e a evitare la fucilazione dei nazifascisti. Tra i dirigenti partigiani locali, si segnalano anche le figure del medico Marco Antoniotti «Astor», Fausto Bocchi «Gianni» e Olinto Zaghett «Carmelo».
La scuola partigiana e le libere elezioni con il voto delle donne
La IV Brigata Apunana fu da subito impegnata in attività di sabotaggio e guerriglia nei territori di Comano e di Fivizzano, ma ciò che la caratterizzò particolarmente fu la capacità di gestire la vita amministrativa del Comune di Comano, con particolare riguardo ai bisogni degli abitanti, a partire dall’istruzione scolastica. Nacque una scuola partigiana intitolata a Ubaldo Cheirasco, studente universitario e partigiano, che si trovava insieme agli uomini del Monte Barca, poi fucilati a Valmozzola. Fu proprio grazie all’intervento di Cheirasco che si salvò dalla morte certa un uomo di Comano, Mario Galeazzi, graziato all’ultimo minuto perché i suoi compagni fanno cadere le accuse nei suoi confronti, facendo credere ai fascisti di averlo arruolato a forza tra i partigiani.
La scuola partigiana fu organizzata per andare incontro alle esigenze dei giovani studenti sfollati e dei numerosi partigiani studenti che, a causa degli eventi bellici, furono costretti ad abbandonare gli studi. Fu articolata in due gradi di istruzione: medie inferiori e superiori, con indirizzo classico, scientifico, magistrale e tecnico; le prime spese furono a carico della IV Brigata Apuana, ed erano previsti aiuti per chi avesse difficoltà finanziarie per pagare l’iscrizione. In un documento della scuola, del 15 gennaio 1945, rivolto al Provveditorato agli studi di Massa, si dichiara l’intento di defascistizzare l’istruzione, dopo gli anni del regime: «risulta abolito l’insegnamento della cultura fascista, del diritto e dell’economia corporativa e ogni insegnamento è stato riportato alla sua funzione storica e scientifica, spogliandolo da ogni sovrastruttura tendenziosa, soprattutto per quanto riguarda la storia politica». La scuola venne organizzata dal prof. Italo Malco, dal maestro Remigio Lucini e dallo studente di Lettere Edoardo Savino Maloni. Il 25 febbraio 1945, si tennero a Comano le elezioni amministrative comunali, libere e democratiche, che videro anche la partecipazione al voto, per la prima volta delle donne (come accadde assai raramente sotto occupazione). Fu eletto a larghissima maggioranza Marco Antoniotti, medico e partigiano, di tendenze liberali. La Brigata inoltre pubblicava un periodico e gestiva spacci alimentari che vendevano generi di prima necessità a prezzi calmierati, in modo da aiutare la popolazione allo stremo. La IV Brigata Apuana fu l’unica a scampare ai terribili rastrellamenti dell’autunno e inverno 1944 e nel mese di marzo del 1945, congiuntamente alla Brigata Garibaldi “Leone Borrini”, fu costretta dalla Missione Alleata di Rigoso a confluìre, non senza dissensi, nella Divisione tosco-emiliana Monte Orsaro, che univa le brigate del territorio parmense con quelle della Lunigiana.
Un episodio controverso è l’uccisione del parroco di Comano don Sante Fontana, attribuita ad alcuni partigiani della IV Brigata Apuana, che negarono gli addebiti, ma ammisero di aver raccolto informazioni sul suo conto. Si creò un drammatico conflitto interno, sia tra i partigiani, sia tra gli abitanti di Comano: alcuni giudicarono il religioso un delatore e quindi un pericolo per la Resistenza e la popolazione che la sosteneva (tra i capi d’imputazione, quello di aver letto i bandi di arruolamento alle armi della RSI dal pulpito), mentre altri giudicarono il suo comportamento dettato da una prudente neutralità e pertanto sostennero che l’omicidio non ebbe una reale funzione bellica, ma sarebbe stato determinato da ragioni politiche e personali
Verso la Liberazione, l’ultima battaglia
Tra il 21 e il 22 aprile del 1945, la IV Brigata Apuana e la Brigata “Leone Borrini” costrinsero alla resa numerose truppe di tedeschi e fascisti, di cui almeno un migliaio furono portati prigionieri proprio a Comano, sede del comando della IV Brigata Apuana. Nella notte tra il 22 e il 23 aprile, hanno inizio le prime azioni di sabotaggio di ponti, strade e gallerie, allo scopo di isolare Aulla. Alle sei del mattino si verifica il passaggio sulla strada di truppe tedesche con carri armati e pezzi d’artiglieria. Alle tredici una colonna di tedeschi e di repubblichini provenienti dalla Spezia e diretti a Nord entra nell’area di tiro dei Battaglioni e cominciano combattimenti che vanno avanti per tutto il pomeriggio, ai quali partecipano anche l’artiglieria americana e aerei anglo-americani. Verso sera, giungono in aiuto dei nemici artiglierie tedesche, il comandante «Dany» porta i suoi battaglioni sul monte Metti, mentre all’alba del 23 aprile la battaglia infuria a Podenzana. Il 24 aprile giunge la notizia che i tedeschi hanno lasciato La Spezia e che la riva destra del Magra è in mano partigiana, ma il nodo stradale di Aulla è sempre in mano nemica. I partigiani intanto fanno sortite verso Terrarossa, mentre le truppe alleate transitano a Isola di Caprigliola. La mattina del 25 aprile, i battaglioni della Brigata Val di Vara conquistano l’una dopo l’altra le posizioni nemiche e la liberazione è raggiunta quando ai partigiani si uniscono due colonne americane che arrivavano da Nord-Est e da Sud.